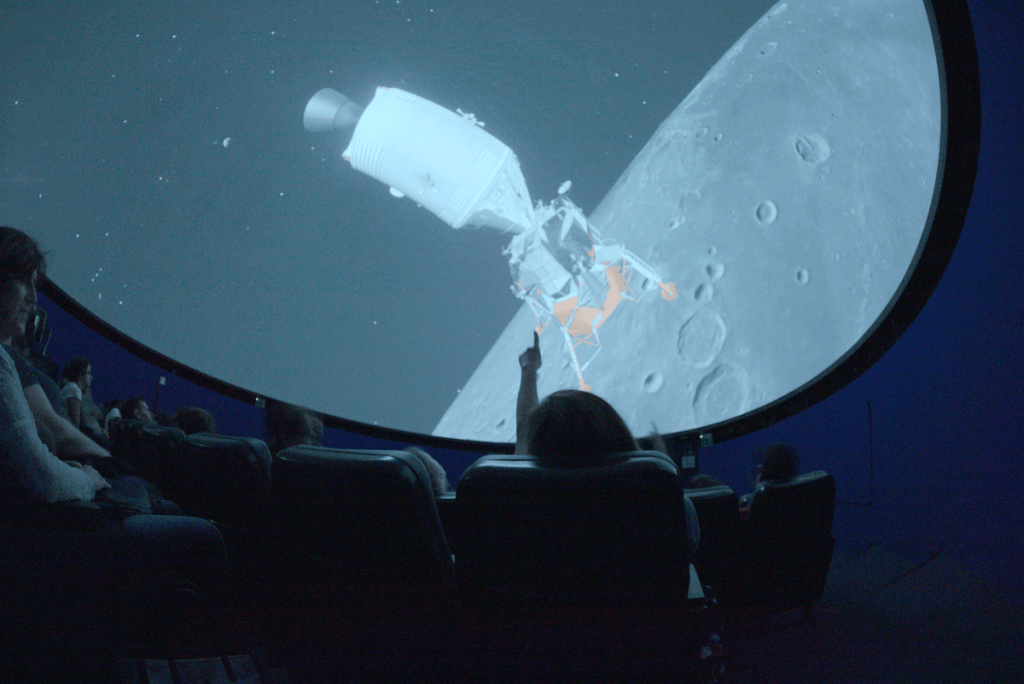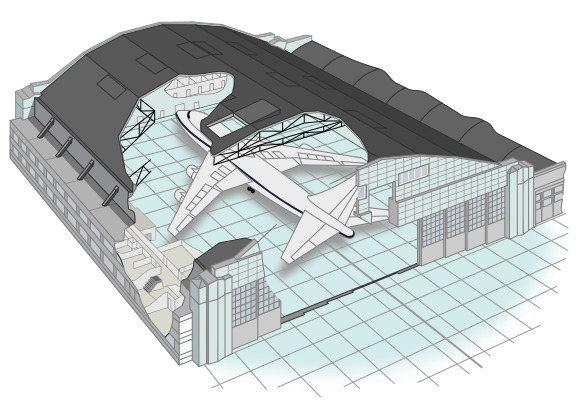Quella di Sarla Thakral è una storia che merita di essere raccontata a voce più alta.
Sì, perché questa ragazza nata a Nuova Delhi all’inizio del secolo scorso ha dovuto far sentire la propria voce forte e chiara per ottenere il primo brevetto di volo concesso a una donna in India.
Sarla nasce nel 1914 da una famiglia di vedute aperte, per quell’epoca. Nonostante l’educazione moderna ricevuta e l’ambiente agiato al quale i suoi genitori appartenevano, si sposò a quella che per ogni ragazza indiana era considerata la giusta età da marito: sedici anni.
Fu proprio grazie al marito, il Capitano P.D. Sharma, che la giovanissima Sarla iniziò ad appassionarsi al volo. Sharma era un uomo intelligente e aperto al progresso, nonché il primo tra gli indiani a conseguire la licenza di pilota di posta aerea. Così, dopo un addestramento e mille ore di volo accumulate su un aereo del Lahore Flying Club, la Thakral divenne la prima donna in India a ottenere una licenza di volo di tipo “A”. E lo fece indossando un coloratissimo sari indiano e camminando a testa alta di fronte alle critiche. Per questo nessuno osò mai ostacolarla.
Purtroppo però, lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e la morte improvvisa del marito fecero sfumare il sogno di Sarla di ottenere il brevetto successivo di pilota commerciale. Con un figlio da crescere e la capacità di adattamento di un camaleonte, l’aviatrice si trasformò presto in una brillante designer di tessuti, nonché in una pittrice di successo grazie al diploma in Belle Arti conseguito presso la Bengal school of Painting.
Fu pilota, moglie, madre, imprenditrice e artista, ma soprattutto una donna felice.
In una sua dichiarazione disse: “Always be happy, it is very important for us to be happy and cheerful. This one motto has seen me tide over the crises in my life.” (“Sii sempre felice, è molto importante essere felici e positivi. Questo è il motto che mi ha permesso di superare le crisi della mia vita.”)