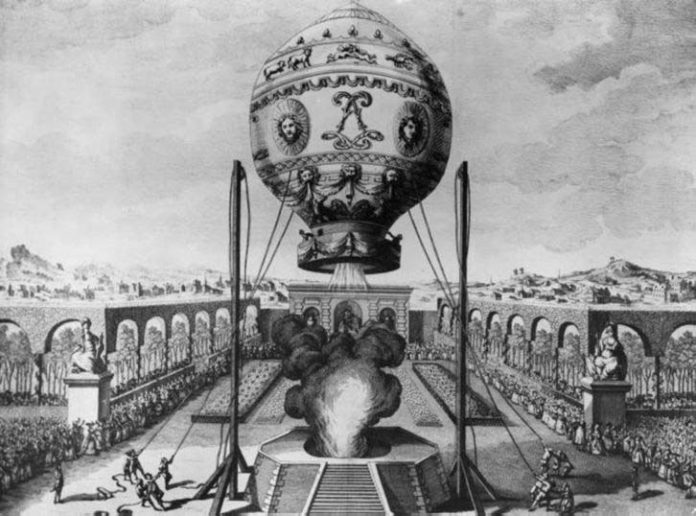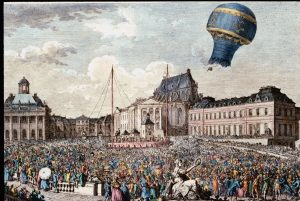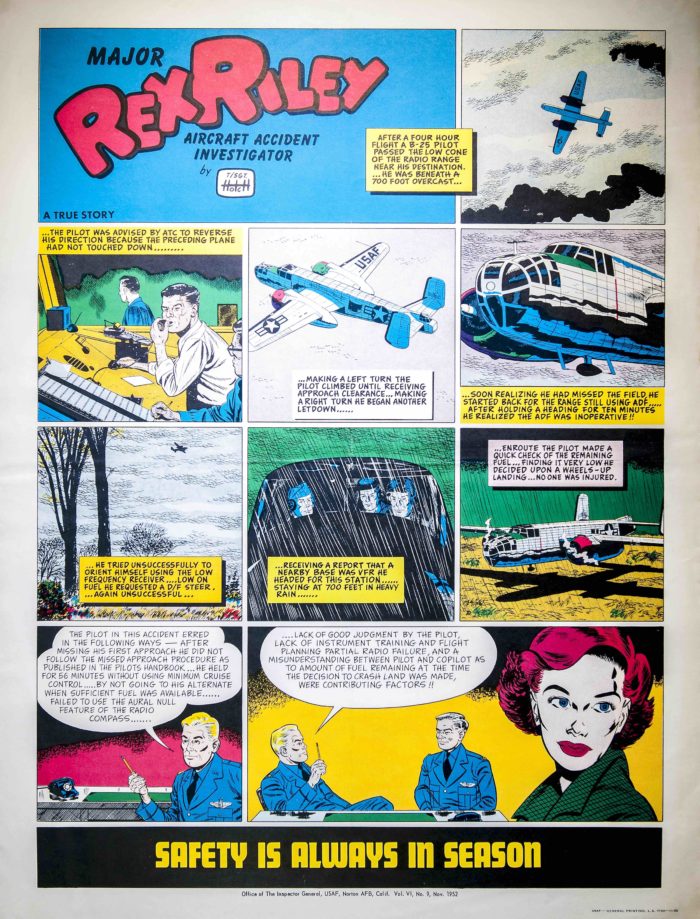Bagagli pronti, sorriso stampato in faccia, la mente già a destinazione…
Niente può andar storto con quelle favolose scarpe nuove di zecca chiuse bene in valigia insieme all’immancabile costume da bagno. Non manca niente, c’è perfino un libro extra se in questo viaggio ti dovessi riscoprire divoratore di romanzi.
Corsa forsennata in aeroporto (ma c’è tutto il tempo e poi “…Dai, ma chi è che perde un aereo?”) e solo un po’ di fila ai controlli… In una mano il telefono, nell’altra il trolley e…
PA-NI-CO.
Hai dimenticato la cosa più importante. Sei un disastro, lo dice sempre anche tua madre. Ma non disperare. Forse ancora non sai che il tuo problema si può risolvere.
DOCUMENTI PERSONALI. In moltissimi aeroporti è oggi possibile richiedere il rilascio immediato della carta d’identità presso gli sportelli dedicati. Informati, prima di disperare, perché potresti ottenere un nuovo documento letteralmente… “al volo”. Se invece sei in partenza da un Paese diverso da quello di cittadinanza, ma in area Schengen, puoi denunciare lo smarrimento della carta d’identità e rientrare a casa solo con la copia della denuncia.
DOCUMENTI DI VIAGGIO. È davvero il caso di rilassarti. Hai dimenticato la carta d’imbarco cartacea in cima alla pila di scartoffie sulla tua scrivania? È ancora nella tua casella e-mail in versione elettronica (benvenuto nell’era degli e-gate!) e certamente il banco del check-in potrà emetterne una nuova, qualora fossi un fan della carta stampata. Stessa regola per prenotazioni di hotel, appartamenti, automobili. Il tuo viaggio è tutto nel tuo smartphone e adesso che ti sei rilassato non dirci che non lo sapevi…
FARMACI. Partire senza un farmaco importante per la tua salute può essere un problema serio. Non fare sciocchezze! Nei principali aeroporti c’è sempre un medico a disposizione e troverai senz’altro una farmacia in cui acquistare il medicamento necessario. Per esempio, nell’aeroporto Franz Josef Strauss International Airport di Monaco di Baviera è presente la Airport Clinic M, che offre ai passeggeri in transito un servizio di assistenza medica con diverse specializzazioni.
PORTAFOGLI. Nei principali aeroporti sono presenti banche ed uffici postali. Se non hai la fortuna di imbatterti nella tua stessa banca, che potrebbe risolvere il problema in un batter d’occhio, richiedi una carta di credito ricaricabile provvista di codice IBAN che non implichi l’apertura di un conto corrente. Avrai senz’altro un amico o un parente gentile disposto a versare sulla nuova carta la somma di denaro necessaria ad affrontare il tuo viaggio. E ricordati, al tuo ritorno, di portare al tuo angelo custode un bel souvenir!
Insomma, caro viaggiatore distratto, tutto (o quasi) si può risolvere, ma tu per sicurezza salva questo blog post tra i preferiti del tuo browser e non dimenticarti di leggere i nostri consigli!